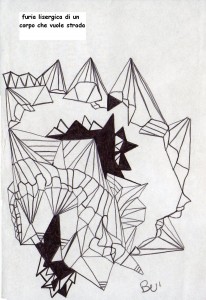“I filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta ora di trasformarlo”. Recitavano grossomodo così due giovani ed entusiasti pensatori nel lontano 1845. A circa un secolo e mezzo di distanza da quel potente motto rivoluzionario, l’invito sembra rimasto per molti versi inevaso. Certo, gli anni nel frattempo trascorsi ci hanno consegnato grandi trasformazioni, anche radicali. Per noi oggi, tuttavia, la questione continua a porsi in modo pressante. Quelle parole appaiono ai più, nel peggiore dei casi, vuote ed insignificanti; nel migliore, ideologiche e senza dubbio superate.
Sarà questo il motivo per cui -mi son detto- io stesso, figlio legittimo della rivoluzione informatica, trovo così complicato provare a ragionare intorno al tema dell’uomo, della dignità e del lavoro. Eppure la cosa un po’ mi lascia interdetto: se una laurea in filosofia –ho pensato- non serve neppure ad affiancare il pensiero in una riflessione intorno a concetti in apparenza molto familiari, naturali quasi, allora il problema è serio. Fermo restando che il problema potrebbe essere tutto e solo mio, personalissimo. D’altronde non ho mai lavorato; forse l’idea di uomo alla quale ci formano le università di filosofia (di donne in effetti si parla molto poco, in quelle università) è troppo astratta, ideale, e in quanto tale inadatta a comprendere la reale portata di un concetto molto concreto, corporeo, quale quello di uomo. E poi la dignità: bellissima parola, ma dove si trova? Che cosa intendiamo quando ne parliamo? Credo che neppure Platone le riservasse un posto nel suo iperuranio.
Allora ho provato con un esperimento. Mi sono azzittito; messo in ascolto; ho riposto la penna nell’astuccio e mi sono detto: “Non scriverai nulla fino a che non ti sembrerà di avere qualcosa da dire”. Che poi io, sia detto per inciso, alla scrittura preferisco il dialogo, o la lettura. C’è in effetti tutta un’atmosfera del dialogo che secondo me nella carta stampata è inevitabile che si perda. Dove vanno a finire gli odori, gli sguardi, i rumori, i movimenti tipici di un dialogo tra due o più persone quando scriviamo sulla carta (o salviamo in pdf)? C’è chi sostiene che le parole, una volta scritte, non appartengano più al suo autore, ma entrino nel vissuto di chi legge e le interpreta a partire da se stesso. Vero, senza dubbio. Un’altra cosa è certa: che sia orale o scritta, la comunicazione, se virtuosa, è sempre arricchente ed in ogni caso irriducibile allo scambio più comune di oggetti. Se infatti ci scambiamo un’idea a testa, alla fine io e te avremo due idee per ciascuno; se ci scambiamo una matita, alla fine io avrò la tua, di matita, e tu la mia: una per ciascuno. E poi i silenzi … Dove vanno a finire i silenzi tipici del dialogo nello spazio ristretto di un racconto? Forse nella punteggiatura? Ma nell’epoca dell’ipercomunicazione diffusa, della connessione perenne, del “digito ergo sum”, del tutti hanno diritto di parlare di tutto con tutti, forse potrebbe avere senso riannodare i fili di un ragionamento serio sul silenzio. C’è di più: sembra quasi che noi abbiamo l’obbligo di avere un’opinione; il diritto di parola va, come in un paradosso, trasformandosi nel dovere di esprimersi, forse per non interrompere il flusso continuo e quotidiano delle banalità. Quanto è raro e insieme liberatorio, al contrario, dire o sentirsi dire: “Non lo so, ci devo pensare”.
Tornando a noi, e per quanto mi riguarda, il silenzio non è stato molto produttivo. Ci ho pensato, ma non saprei come dire di lavoro, di dignità e di uomo. Forse i problemi sono quelli a cui accennavo; o forse la mancanza di contenuti, l’incapacità di trovare una forma espressiva adatta: o forse entrambe le cose. In realtà qualche idea mi è venuta in mente, ma si è trattato di storie immaginate il cui filo è andato sfumando, confondendosi nei fili di altre storie a loro volta interrotte. L’interpretazione, appunto. La molteplicità delle interpretazioni.
La prima cosa a cui ho pensato è stata: è una constatazione fin troppo lapalissiana notare che, al giorno d’oggi, l’uomo si costituisce in opposizione al lavoro e alla dignità. Non intendo gli uomini concreti, in carne ed ossa, che di lavoro ne avrebbero evidentemente bisogno. Intendo il modello di uomo al quale il globo intero è andato omologandosi: l’uomo occidentale, maschio, produttivo e competitivo, dominatore della natura, dello spazio e dei suoi simili. Questa nuova specie di Homo demens, che in nome del mito della competitività pretende di ridurre la madre terra ad un grande supermercato globale. Con tutte le contraddizioni che ne derivano: inquinamento dei suoli e dell’aria, per non dire delle menti; sfruttamento generalizzato del lavoro; infelicità diffuse, sorveglianza e repressione, annullamento di ogni spazio di convivialità non mercificata. Quanto è grande la potenza del mito, anche in un’epoca storica che crede di essersene affrancata in modo definitivo, dominata com’è dal dogma razionalistico della scienza panacea di tutti i mali! Ma come narrare di uomo, dignità e lavoro a partire da tali presupposti? Chi ci riesce è bravo. E poi: non sarà che questo modello interpretativo è, per l’appunto, eccessivamente astratto, troppo concentrato sull’oggi e forse ideologico? Non oso neanche immaginare le obiezioni degli addetti alla difesa dell’ordine costituito. Infatti mi sono perso, non ho più trovato il filo, come dicevo. Per di più, questa visione delle cose, che doveva fare da cornice ad un eventuale racconto breve, è parziale: non perché assuma il punto di vista di chi subisce lo stato attuale delle cose, ma perché ce lo rende menomato delle tante grandi e piccole storie che vanno costituendo, a conti fatti (a manuali scolastici editi), la Storia, quella con la S maiuscola.
Allora ho pensato di concentrarmi sul lato delle storie, quelle dei conflitti, autentici ed ineliminabili motori della Storia. Non si possono liquidare con un sol colpo –mi sono detto- centinaia se non migliaia di anni di lotte e rivendicazioni in nome del lavoro e della dignità, o della dignità del lavoro. Lotte che peraltro, a dispetto di quanto voglia farci credere la stampa irreggimentata, proseguono ancora oggi, sparse in ogni angolo del pianeta, ed anche nella nostra piccola e sfasciata penisola. Lotte, quelle sì, portate avanti con coraggio e dignità da uomini e donne in carne ed ossa: operai costretti a dimenarsi nell’ingiusta contrapposizione tra salute e lavoro; agricoltori che vedono i propri campi recintati per lasciare il posto ad un’autostrada, una ferrovia, un ponte, come se fossimo ai tempi del protoindustrialismo inglese; insegnanti (precari e non) e studenti obbligati a districarsi tra saperi funzionali al mercato lavorativo e perciò dequalificati, istituti fatiscenti, stipendi dimezzati. Sindaci, anche, che ogni giorno, in nome del risanamento del debito, si scoprono impossibilitati a garantire i minimi servizi sociali ai propri concittadini: asili, trasporti pubblici, scuole, appunto, ospedali. Lotte che fanno parte di un panorama molto più ampio e condiviso, del quale è sempre bene serbare e rinvigorire la memoria collettiva, in un mondo a misura di bit. Potrei scrivere una storia –ho provato anche a delinearne i tratti nella mia mente- in cui provare a costruire e riprodurre la vita individuale di uno o più personaggi coinvolti in una delle molte lotte condotte in nome dell’uomo, della dignità e del lavoro. Chessò, gli anabattisti tedeschi, i rivoluzionari francesi, i sindacalisti statunitensi tra otto e novecento, i giovani europei nel settantasette. Ed innumerevoli altre storie, pronte a riemergere dove meno te lo aspetti, quando meno te lo aspetti; sotto altre forme, ma mosse dai medesimi slanci ideali. Lotte non vincenti, non sconfitte. Il lettore avrebbe scoperto di non essere solo: che in altri tempi, e in altri luoghi, si sono mosse altre persone ricche della propria singolarità, con le loro rabbie e le loro gioie, gli affanni, gli scoramenti, le speranze e le delusioni, con i propri errori e i sogni non conclusi, mai domati. Insomma, mi sarebbe piaciuto scrivere di quel crocevia così affascinante in cui la Storia va ad intersecarsi alle storie, per ritrovarsi mutata. Trasformata. Ne ho lette parecchie di storie così; mi piacciono. Mi piace immaginare altra gente normale, come me, come noi adesso (potrà sembrare strano, ma il mondo è pieno di persone normali) coinvolta nei grandi destini dell’umanità, chiamata a fare parte dell’imprevedibile spettacolo del mondo. Mi piace dimenticarle, anche, queste storie. Per poi rendermi conto di come tornino improvvise in mente, a volte chiare, a volte confuse, ad arricchire il mio immaginario. Già, l’immaginario: forza demolitrice e creatrice, disorganizzante e costantemente aperta all’esplorazione di possibilità altre di organizzazione. L’immaginario creativo è qualcosa di speculare ed opposto al mito dogmatico, di cui prima si sottolineava la potenza e la pericolosità. Spesso gli opposti finiscono per incontrarsi, per confluire l’uno nell’altro fino al punto di non riuscire più a distinguerli. Eterogenesi dei fini, la chiamano alcuni: la storia ne è piena zeppa di esempi. Ma l’attitudine ad immaginare altri orizzonti possibili è, per quanto mi riguarda, inversamente proporzionale alla mia capacità di raccontarli.
Eppure ci ho provato. Mi sono detto che il fatto di non riuscire a raccontare una storia che parlasse in modo semplice dell’uomo, della dignità, del lavoro dipendeva dalla limitatezza delle prospettive che avevo elaborato. La correttezza di una risposta dipende spesso dall’adeguatezza della domanda: e bisogna essere molto creativi per porre le domande giuste. In questo senso, quello che consideriamo il processo di maturazione individuale potrebbe benissimo non essere altro che un processo, mi si passi il termine, di rimbambimento insieme individuale e collettivo. Chi più dei bambini, infatti, è portato a porre domande spiazzanti, fantasiose e stimolanti per la mente spesso svogliata degli adulti? Lasciamoli crescere liberi, per piacere! Ho provato dunque a immaginare i contorni di un racconto fantastico, ambientato nel futuro, nella comunità di Utopia. Potrà sembrare scontato, ma il termine utopia è proprio quello giusto per indicare ciò di cui sto parlando. Utopia è un non-luogo ma anche una società ben fatta, ben organizzata. La mia Utopia è un posto non privo di conflittualità, non è una comunità armonica ed equilibrata in modo meccanico come un orologio. Il suo equilibrio interno ed esterno, piuttosto, è regolato dalla volontà stessa dei suoi membri che si riconoscono limitati e bisognosi l’uno dell’altro. Risolvono le controversie dialogando, qualche volta finiscono anche alle mani, ma nessuno di loro ha più diritto degli altri di esercitare la propria forza: è la comunità stessa che funge da deterrente in questo senso. Il bene condiviso è ciò che spinge gli uni a collaborare con gli altri, nel lavoro manuale e intellettuale, nel privilegio del valore d’uso e non di scambio delle cose, nell’utilizzo della moneta solo se e quando necessario. Una comunità che coltiva l’ozio, che rispetta la dignità del bimbo e dell’anziano, degli esseri viventi in generale, il meno invasiva possibile nei confronti della natura. I suoi membri lavorano proprio per rimediare agli scempi che trecento anni di sviluppo industriale scriteriato hanno causato alla madre terra. Così c’è lavoro e dignità per tutti: il lavoro è faticoso, specie quello nei campi, ma non è più uno stress; spesso ci si aiuta volentieri e ciò contribuisce a renderlo meno gravoso per ognuno, persino piacevole a volte. I lavoratori impiegati sia nei campi sia nelle industrie si gestiscono da loro: non hanno capi a cui dover rendere conto. Allo stesso modo, non ci sono capi politici, solo delegati che di tanto in tanto si riuniscono a livello planetario in lunghe discussioni che possono durare anche anni, nelle quali si studia e si analizza lo stato di salute della terra e ci si confronta sui diversi modi che le diverse comunità locali utilizzano per organizzarsi. Molti hanno rinunciato a quelli che noi consideriamo beni indispensabili: macchine lussuose, tanti soldi, televisioni, elicotteri o addirittura armi. Queste sono state bandite, di comune accordo. Alcuni utilizzano ancora lunghi coltellacci per uccidere gli animali di cui cibarsi; a volte sono gli animali ad avere la meglio. In molti, tuttavia, preferiscono non mangiare affatto carne. Lo stesso vale per la pesca. Per comunicare tra distanti si utilizzano ancora i computer, ma la maggior parte delle persone non ne possiedono tre o quattro per casa. Ce ne sono un certo numero sparsi per il territorio di riferimento e chiunque può servirsene liberamente, ma essendo molto forte, ovunque si vada, il senso di solidarietà e di appartenenza comune alla terra non c’è bisogno di comunicare quotidianamente neppure con i propri familiari: ci si sente a casa un po’ ovunque e c’è un grande senso diffuso di amore per la scoperta. Ci si è adoperati molto per esplorare le potenzialità inespresse del cervello umano, alcuni sanno comunicare grazie alla telepatia. Si ricicla di tutto, e si costruiscono strumenti di ogni tipo, e per gli usi più diversi, con gli scarti di cui la società industriale era ricolma. Interi quartieri industriali delle grandi ex-metropoli sono stati recintati: ora ci sono dei teatri o dei centri culturali per tenere viva la memoria riguardo a quello che fu. Alcune industrie, tuttavia, sono state riconvertite in chiave ecologica. Molte persone hanno preferito tornare a vivere nelle campagne, per ritrovare un contatto con la natura ed avere ciò di cui cibarsi: tuttavia altri vivono ancora in grandi città, che sono poi degli agglomerati di tanti diversi quartieri che riproducono su scala micro il funzionamento più complessivo della società nel suo insieme. C’è molto spazio per le feste, per i giochi e per la cura di sé e degli altri vicini. Le relazioni sociali e mercantili sono costituite alla base dalla gratuità e l’economia ruota attorno alla pratica del dono …
Ritengo che questo che ho appena vagamente tratteggiato sia un esperimento molto utile. A me, almeno, è servito. Se potessi scegliere per gli altri, istituirei a scuola l’ora di utopia. Tuttavia, non ho concluso neanche questa storia. Questa volta, però, non per incapacità o svogliatezza personale. In tal caso il problema sta più a fondo, è un problema strutturale: le utopie si possono costruire solo collettivamente, grazie all’apporto e al contributo di ognuno. Il realista politico che fosse suo malgrado incappato in questa strana storia, la considererebbe un gioco per bambini, nel migliore dei casi, o richiederebbe il mio internamento in qualche struttura psichiatrica. Ai realisti rispondo così, con un altro breve racconto, che poi è anche l’ultimo che mi è frullato in testa provando a ragionare di uomo, dignità e lavoro. Non posso dirlo con certezza, ma potrebbe anche essere molto simile ad uno dei sogni che ho fatto l’altra notte:
da qualche giorno i telegiornali avevano annunciato un evento del tutto strano e imprevisto. Non che non fosse mai successo prima, ma eravamo abituati di solito ad assistervi solo in circostanze del tutto eccezionali, come lo scoppio di una grande guerra in cui i nostri governanti avevano deciso di partecipare o l’inizio di un nuovo anno: il governo tecnico, riunitosi in grande stile, decideva di rivolgersi a reti unificate alla nazione. Si temeva il peggio: c’era chi sospettava appunto proprio l’ingresso in una qualche guerra sparsa nel mondo di cui dovevamo aver perso negli ultimi tempi le coordinate ma che sicuramente, in quanto fiera nazione italiana, ci riguardava: questo i più catastrofisti. C’era poi chi riteneva che tramite qualche esperto di profezie, un sottosegretario magari, uno meno in vista dei ministri sempre esposti alle luci dei riflettori, uno che fa il lavoro sporco insomma, si fosse riusciti ad avere delle notizie certe ed inconfutabili che confermavano la sciagura ormai da tempo predetta dagli illustri Maya: in previsione di ciò, molti cittadini italiani, già di indole inclini come si sa alla superstizione, avevano riattrezzato i bunker antiatomici in uso nella seconda guerra mondiale: chi non ne aveva uno, si preparava a rifugiarsi nel garage o nello scantinato. Nessuno credeva alle profezie, ma se fossero stati i tecnici a confermarle … C’era poi chi, forse più catastrofista dei catastrofisti convinti dell’ipotesi guerrafondaia del governo, temeva che questo stesso avesse deciso per un’altra finanziaria: il cresci-italia doveva attendere; bisognava prima rendere più efficaci le manovre di riduzione dei debiti: ancora taglia-italia, dunque. Secondo qualcuno, che sosteneva di aver ricevuto indiscrezioni non si sa tramite quali amici di amici di amici di un certo deputato a Roma, da quella manovra in poi sarebbe stata varata una nuova bolletta: la bolletta dell’aria. Chi non pagava avrebbe visto chiudere i propri rifornimenti di aria e arrivederci: si sarebbero risolti così, esultavano già i più pragmatici, due problemi in un solo colpo. Le casse dello stato si sarebbero di colpo riempite e il problema di molti cittadini che non riuscivano più a vivere degnamente si sarebbe risolto alla radice: sarebbero morti per asfissia. Arrivò dunque il grande giorno, o meglio, la grande sera: noi guardammo l’edizione trasmessa dal tg1 delle Venti, il più adatto, eravamo d’accordo, a seguire questo genere di eventi. Quando fu aperto il collegamento con la camera dei ministri, gli stessi si erano già sistemati dietro la lunga scrivania e fissavano chi la telecamera, chi il blocchetto di appunti sparsi dinanzi a sé, chi semplicemente a terra o in qualche punto tecnicamente imprecisabile. Seguirono dei minuti di silenzio; l’aria sembrava tesa, seria e la situazione complessivamente tetra: fu il professore, dopo lunghi minuti di pausa che sembrarono durare delle ore per il popolo che pendeva dalle sue labbra, ad avvicinare il microfono alle stesse. Finalmente parlò. E disse: “Scusateci- ci tenne a precisare che parlava in nome dell’intero parlamento-. Noi non siamo altro che degli imbroglioni patentati, sono decenni, se non centinaia di anni che vi raccontiamo bugie su bugie. Tutto il sistema è corrotto, non stiamo parlando di singole responsabilità individuali. Da questa sera torniamo ad essere privati cittadini, dopo aver valutato la questione con gli altri capi di stato in un vertice segreto. Gli altri leader europei e mondiali stanno dicendo le stesse semplici parole ai propri concittadini. Se lo vorrete, ci rimetteremo al vostro giudizio; il nostro destino è nelle vostre mani. Ma soprattutto, da oggi il vostro destino è nelle vostre mani, come non lo è mai stato prima. In bocca al lupo, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Che il viaggio intrapreso sia lungo e fecondo. Evviva la democrazia”. Ma il peggio doveva ancora avvenire. Si alzarono quasi in contemporanea dalle loro sedie, e visibilmente erano tutti affranti e prostrati. Una volta in piedi, ecco la scioccante sorpresa: nessuno di loro indossava né pantaloni né gonna, erano rimasti tutti in mutande. Come mamma li aveva fatti, quasi, e per fortuna non del tutto. Qualche giornalista più estremista ne approfittò per rifilare un sonoro calcio nel sedere a quei culi vecchi. Ma fu l’unico episodio di violenza, se così si può chiamare. Da quel giorno il popolo si rimboccò le maniche e ci fu come una nuova nascita. Anche i realisti politici collaborarono.
Ho deciso che neanche questa storia valeva la pena di raccontarla, di approfondirla troppo. Mi sono divertito ad immaginarla, però. Ma soprattutto –mi sono chiesto- perché tanta ostilità nei confronti di questi miti professori, tecnici di professione e politici contro la loro stessa volontà? In fondo anche loro hanno la propria dignità di uomini e donne. E fanno solo il proprio lavoro.
ROB